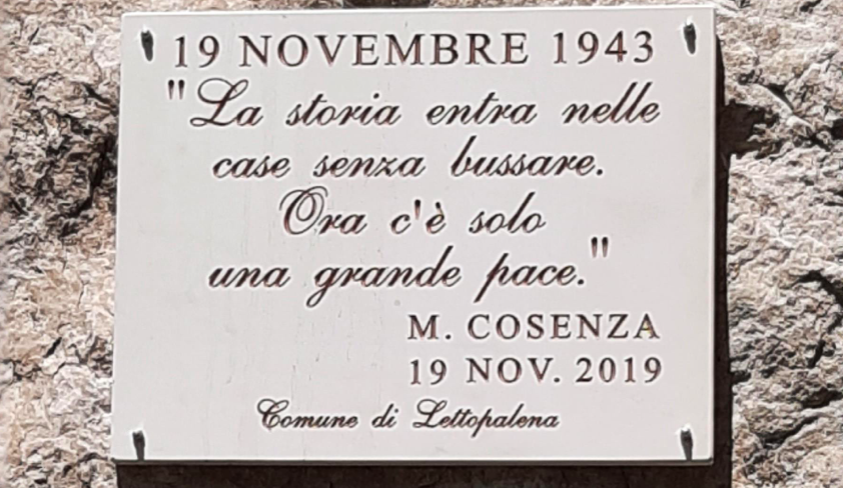Cocciuta. Calabrese. Qualsiasi centro di ricerca nel mondo farebbe ponti d’oro per averla, lei invece no: resiste nella sua terra, non si muove da Lamezia e si batte con i denti per il suo centro di neurogenetica. Le sue scoperte hanno permesso di svelare molti segreti dell’Alzheimer, la quarta causa di morte in età adulta, fino a non molti anni fa una malattia vissuta segretamente in casa o in un manicomio, ventiduemila ammalati in Calabria. Rita Levi Montalcini, ovviamente più che ricambiata, la adora, la Calabria, raramente generosa verso i suoi figli, un po’ meno. Amalia Bruni è un fascio di nervi, emozioni e passioni. Il suo viaggio nel cervello dell’uomo è un’esplorazione iniziata molti anni fa. Ha giocato molto la sua determinazione ma un ruolo lo ha avuto il destino.
Lei è nata a Girifalco, città del manicomio. Un segno premonitore?
«Sono nata per caso a Girifalco. Poiché nel 1955 si partoriva in casa, il parto fu realizzato sotto l’occhio vigile di mio nonno che era il medico condotto di Girifalco. Mio padre, un giovane belloccio, fu il primo preside e professore della scuola media nascente, conobbe la bella figlia del medico del paese, se la impalmò, poi incominciò a errare nella Calabria per insegnare. Sono nata a Girifalco mentre passava la processione della Domenica delle Palme, tant’è che uno dei miei soprannomi da piccola era Palmina, che io detestavo. Infatti ricattavo tutti: se mi dai tre fichi secchi – ne ero golosissima – mi faccio chiamare Palmina».
Quindi, non ha vissuto a Girifalco?
«No, però ho recuperato la memoria di questo paese e del suo ospedale psichiatrico quando ho cominciato a lavorare sull’Alzheimer».
Ci arriveremo. L’infanzia dove?
«A Lamezia, a Nicastro, dove mio padre era stato trasferito. Liceo classico, scout da piccola, caposquadriglia, poi crisi esistenziale, Udi».
Passò dagli scout di area cattolica all’Unione Donne Italiane dominata dai comunisti.
«Non ci ho mai visto differenze, perché ho sempre ritenuto l’uomo l’oggetto di interesse».
L’università a Roma?
«No a Napoli. La decisione fu un po’ sofferta. Volevo scegliere psicologia che all’epoca era o a Roma o a Padova. Ma c’era già un fratello all’università di Napoli per cui mio padre disse: figlia mia, o lì o lì, tuo fratello è già a Napoli, due figli nella stessa casa riesco a mantenerli, diversamente no. Rimuginai e decisi di arrivare allo studio del cervello attraverso il percorso della medicina».
Dove si iscrisse?
«Al Secondo Policlinico. Al terzo anno mi presentai alla clinica dove fuori c’era scritto “malattie nervose e mentali”. Entrai per chiedere l’internato, avevo fatto una corsa per dare tutti gli esami utili. La clinica era già divisa tra psichiatria e neurologia ma nessun cartello lo faceva capire. Per caso capitai al piano terra dove c’era la segreteria del professore Buscaino, mentre al piano di sopra c’era il professore Rinaldi. Fosse successo l’inverso sarei diventata psichiatra».
Perché l’attraeva il cervello?
«Mi ero sciroppata un trattato di psicoanalisi e mi affascinava capire il perché dei comportamenti umani».
Freud, Jung, a quell’epoca era fortissima la suggestione che esercitavano sui giovani. Anche su di lei?
«Ero piena delle idee del mio tempo. Diciamo che ho ricostruito e sanato tutto questo percorso nell’ottica della neurofisiologia. Ho capito poi di aver fatto la scelta giusta perché la trasposizione filosofica è importante ma i dati dell’esistente non possono essere negati».
La scienza?
«La scienza vera, quella inconfutabile. Prenda lo shiatsu. I cinesi sono stati soltanto dei grandi empiristi nel senso che hanno utilizzato l’osservazione in maniera straordinaria, ma quella che è considerata una filosofia cinese in realtà è neuroscienza dal momento che tutto è spiegato benissimo nell’immenso contenitore del cervello umano».
Si laurea a Napoli?
«In cinque anni, una corsa rapida perché mio padre mi aveva allertato: figlia mia, tu vuoi fare medicina, tieni conto però che è una strada lunga e difficile, sei una donna, forse sarebbe meglio che facessi l’insegnante, ti lascerebbe più spazio. Insomma era forte la mentalità che tu puoi anche studiare, fai una bella figura, però comunque ti devi interessare di casa, famiglia e figli. Il lavoro di insegnante ti dà tre mesi di vacanza, i periodi festivi…».
Una volta.
«Esatto. Presa la laurea nel 1979 chiesi al professore Buscaino di rimanere a Napoli. Mi piaceva l’università, poi eravamo molto pochi all’epoca, tutti giovani entusiasti. Ricordo quante notti a vegliare il sonno dei parkinsoniani per registrare da un punto di vista neurofisiologico ogni variazione, facevamo noi i prelievi. È stata una formazione straordinaria perché non essendoci molto personale eravamo utilizzati come manodopera».
Napoli antica capitale nel bene e nel male, e comunque ancora un faro di cultura?
«Per la mia famiglia Napoli era un punto di riferimento, perché molti miei zii e cugini erano lì. In particolare c’era stato il fratello di mia madre, Salvatore Tolone, un neurologo, allievo di Buscaino il vecchio, morto a 42 anni in un incidente stradale, ma lì era rimasta la sua famiglia, c’era un mio cugino, Romolo, che all’epoca era direttore dell’istituto Pascale».
Era ben seguita?
«Sì, ma Romolo tentò di distogliermi dallo studio della neurologia soprattutto quando realizzò che non sarei rimasta all’università. Devi fare l’endoscopista perché in Calabria non ce ne sono».
E lei come gli rispose?
«Andai per quindici giorni al Pascale a fare le endoscopie: i malati vomitavano da una parte e io vomitavo dall’altra. Non mi interessava minimamente. Io che non avevo mai avuto timore di fronte a un malato in crisi epilettica andavo in bestia per l’endoscopia. Lui insisteva: ritornerai in quella terra, lì c’è solo una neurologia manicomiale».
Lasciò Napoli?
«Non potevo restare, Buscaino mi spiegò che era difficile l’inserimento, tornai in Calabria e feci il tirocinio a Catanzaro, al reparto di neurologia del Pugliese. Contemporaneamente facevo le guardie mediche a Filadelfia dove le ho passate di tutti i colori, e frequentavo la scuola di specializzazione a Napoli da Buscaino dove ero riuscita ad entrare nonostante proprio quell’anno avessero introdotto la lotteria dei test per l’ingresso. Arrivai prima su sessanta».
Una vita piena?
«Una vita folle. Viaggiavo con la mia Renault 4 tra Napoli, Nicastro e Filadelfia».
Un’auto cult. Colore?
«Rossa fiammante. Era sempre nel filone. Tra l’altro mi ero sposata e la mia abitazione era una mansarda. Tutto un po’ bohemien».
Suo marito?
«È di Lamezia. Ho tre figli, un maschio di ventidue anni e due femmine di venti e di quattordici».
Quando incomincia a fare ricerca?
«A quell’epoca c’era solo la ricerca del posto di lavoro. Con mio marito, anche lui medico e scout, c’eravamo ritrovati a Napoli dopo anni di avventure: ci prendevamo e ci lasciavamo, poi ci fu il reincendio. Eravamo convinti che questa terra dovesse avere un riscatto. E siamo tornati per mettere su famiglia in maniera precisa».
Trova il posto di lavoro?
«Venne bandito un concorso per un posto di assistente in neurologia nell’ospedale di Nicastro, partecipai – devo confessare – per non viaggiare più. Quindi, ero anche un po’ amareggiata, mi ricordavo della premonizione di mio cugino. Entrai in questo ospedale, in neurologia. L’unico medico, Giovanni Caruso, per prima cosa mi mise nelle mani un neonato dicendomi: d’ora in poi della parte pediatrica della neurologia ti occupi tu. Volevo morire, io venivo da una scuola di neurologia dell’adulto, i bambini li avevo visti con Salvatore Striano, un maestro in materia al Secondo Policlinico di Napoli. Il primo anno fu folle. Per un periodo ho fatto l’autodidatta, sono stata al Gaslini di Genova per più di un mese a studiare. Ho lavorato con il primario Elisio Scuteri, che ha creato una pediatria e una neonatalogia in questa terra».
Come passa agli adulti?
«I pomeriggi stavo sola, mio marito era in marina per il servizio militare, ancora senza figli, leggevo e studiavo. Poiché non mi sono mai fatta i fatti miei, trovai una corrispondenza sulla scrivania di Giovanni Caruso, una serie di lettere di un tal Jean Francois Foncin della Salpetriere di Parigi che chiedeva la collaborazione per lo studio di una famiglia con l’Alzheimer ereditario. Avevo visto casi strani ma di questo non avevo mai sentito parlare per cui chiesi informazioni a Giovanni. Mi disse che c’era una famiglia che aveva l’Alzheimer ereditario, ma che non era mai riuscito a saperne di più: questa potrebbe essere una cosa importante per te».
E lei?
«Telefonai al professore Foncin, un mito per i neurologi di tutto il mondo, avvalendomi di un tecnico di radiologia che era stato emigrato in Francia e conosceva la lingua. Dopo una settimana Foncin era qui con un computer portatile che gli occupava tutto il bagagliaio, tra l’altro pieno di fieno perché faceva anche il contadino a tempo perso».
Lo scopo?
«Nel 1973 era stata ricoverata alla Salpetriere una donna emigrata a Parigi che dopo aver partorito l’ultimo bambino non voleva allattare il bambino, era incurante, agitata. I neurochirurghi, che avevano sospettato un tumore frontale, facendo la ventricolografia – eravamo in epoca pre-tac – avevano prelevato un piccolo frammento di corteccia, l’avevano messo sul vetrino e l’avevano mandato a Foncin per l’estemporanea. Vedendo la colorazione, Foncin aveva detto: ma quale tumore, questa ha un Alzheimer, ha le placche senili a degenerazione neurofribillare. Enorme la sua sorpresa quando gli avevano detto che aveva 42 anni. Ed era aumentata sentendo il racconto del marito della paziente: veniamo da un piccolo paese della Calabria, nella famiglia di mia moglie sono morti tutti così all’ospedale psichiatrico di Girifalco».
Il destino?
«Straordinario. Foncin aveva capito che era un filone importantissimo da seguire, assolutamente sconosciuto all’epoca: si parlava di Alzheimer come di una malattia molto rara, non si capiva cosa fosse la demenza senile. Foncin aveva chiesto dei finanziamenti al governo francese che li aveva negati accusandolo di voler fare il turismo scientifico. E lui più testardo di un mulo, più testardo di un calabrese, aveva deciso di trovare dei finanziamenti in una fondazione privata».
Venne a Girifalco?
«Nello stesso anno. Prese la cartella della famiglia, ma il lavoro si arenò perché a duemila chilometri di distanza era difficile portarlo avanti. Da lontano scriveva lettere al professore Giorgio Macchi, una delle grandi menti della neurologia italiana, e che al Gemelli era stato direttore di cattedra di Caruso. Per cui come Foncin scriveva le lettere a Macchi, questi le metteva in busta e le mandava a Caruso a Nicastro».
E Caruso le teneva sulla scrivania prima che lei ci ficcasse il naso.
«Infatti il giro si chiude con la mia telefonata a Foncin, che quando seppe che ero nata a Girifalco e che il direttore dell’ospedale con il quale aveva avuto i primi contatti era un mio zio acquisito, disse: la tua decisione per la neurologia è genetica».
È stata fortunata. Quello che cercava era a due passi. Le pare?
«Sì. L’archivista, che conosceva la mia famiglia, la più importante di Girifalco, mi apriva l’archivio di pomeriggio, la mattina lavoravo. Tirai fuori queste cartelle, di cui una bellissima, che ci ha permesso la ricongiunzione con la branca americana studiata in maniera del tutto indipendente da Feldman che nel 1963 – io avevo otto anni – nei ringraziamenti della sua pubblicazione citava l’ufficiale dello stato civile di Catanzaro. In effetti si trattava della prima paziente, da cui ha origine la ricerca americana, di cui ho trovato la cartella nell’ospedale psichiatrico di Girifalco. Una cartella del 1904, cioè tre anni prima che Alzheimer descriva la malattia. È il primo documento storico di un Alzheimer sicuro, perché da questa donna discendono pazienti con mutazione genetica che abbiamo sotto il naso».
Il primo riconoscimento del suo lavoro?
«La tesi di specializzazione. Il professore Buscaino , che si era pentito di avermi fatto andare via, mi disse: è una pietra miliare, te la pubblico. Il professore Macchi mi definì la chiave di volta dell’Alzheimer».
Anche Rita Levi Montalcini è stata prodiga di complimenti con lei.
«L’avevo conosciuta nel 1987. Un anno prima aveva avuto il premio Nobel. Nel febbraio ci fu un grande congresso al Cnr in suo onore. In quel mese fu pubblicato su Science il mio studio sulla prima identificazione del cromosoma 21. Il professore Luigi Amaducci decise di darne l’annuncio nel congresso. Ci fu, quindi, un’eco straordinaria. Nei tempi in cui nasceva la neurologia molecolare, l’idea di identificare il gene dell’Alzheimer nelle due famiglie calabresi su cui stavamo lavorando, aveva avuto un successo incredibile. E fu Amaducci che sapeva in quali condizioni lavoravamo – il servizio di neurologia era in una stanzetta in cui facevamo a turno per respirare –, a propormi di aprire a Lamezia lo Smid Sud, il centro per lo studio multicentrico italiano demenze».
Come andò con la Montalcini?
«La invitai all’inaugurazione e lei mi disse che era onorata di venire. Nacque una simpatia immediata, la mia era abbastanza scontata, ma devo dire che è stato lo stesso per lei. Mi ha voluto bene, forse si è un po’ impersonata con le mie difficoltà».
Le ha dato consigli?
«Non ho mai lavorato con lei, ma mi ha seguito moltissimo. Credo sia ormai un mito, la donna che ha dato tanto e che ha fatto scoperte fondamentali. Un modello assoluto. Anche di longevità. Negli ultimi mesi, per le tante vicissitudini che viviamo, le ho scritto come un figlio si rivolge alla madre nei momenti di necessità, lei è la mia madre scientifica…».
Quando nacque il centro di neurogenetica?
«Nel 1992 Smid cessò le attività. Bisognava riconvertirsi, c’era un piccolo finanziamento del Cnr, si cercava un’unità operativa perché l’ospedale non era più sufficiente, tutto era precario. Passai la terza gravidanza a piatire un posto dove mettere le nostre cose. Il direttore amministrativo Pietro Caligiuri ci diede due appartamenti del consultorio».
A quel periodo risale l’isolamento del gene?
«Era il 1995. Una cosa emozionante. Non ci speravamo. Facemmo una conferenza stampa in comune con il Canada perché il risultato era stato conseguito con lo studio contemporaneo di cinque famiglie. Un clamore enorme. La mutazione condivisa era uguale, probabilmente rimanda all’anno mille. Questa conferenza volli farla con la regione Calabria, mi sentivo di condividere il successo con le istituzioni. Venne il presidente Giuseppe Nisticò, e forse perché la Montalcini gli si era messa nelle orecchie (“fai qualcosa per Amalia”) decise di far nascere questo centro, monco, senza soldi».
Non esageri.
«Non esagero. C’era solo un finanziamento triennale, scelta anche giusta perché dovevamo essere messi alla prova. Però i soldi arrivavano dopo tre anni, nei primi anni con difficoltà estrema, con un finanziamento di privati canadesi realizzammo uno studio sull’umore, abbiamo tirato la cinghia».
Una battaglia continua?
«Sì, direi che questo dei dieci anni non è un compleanno felice. Si celebra una resistenza, non un’esistenza».
Quando avverrà?
«Sto preparando un grande convegno dal 3 al 4 ottobre prossimi in cui celebreremo la resistenza del centro di neurogenetica. Nonostante tutto».
Perché il Sud è condannato a avere questi comportamenti?
«Ce li vogliamo. L’emigrazione ha privato la Calabria della maggior parte delle persone forse più capaci. Sono sempre convinta che quelli che siamo rimasti siamo i peggio non i meglio, i meglio se ne sono andati. Noi abbiamo perso quasi due generazioni, la mia e quella successiva, forse più del cinquanta per cento dei miei compagni di scuola sono fuori. Non c’è stato scambio. Sono state sottratte delle risorse straordinarie. Questa è la verità».
Anche in politica?
«Il problema è di aver visto la politica come qualche cosa di sporco, e nessuno ci si è voluto mischiare. I pochi tentativi fatti, anche a Lamezia con le liste dei movimenti, sono stati penalizzati, perché la politica ha le sue regole durissime, devi essere tagliato in una certa maniera per entrare nel gioco. Non vedo la Calabria difforme dal resto dell’Italia, ma qua i problemi sono acuiti perché manca la normalità, non ci sono procedure certe. Questo centro è andato avanti perché ci inventammo l’associazione di neurogenetica: l’ho fondata perché all’epoca mi avevano vietato di condurre la ricerca nell’orario di servizio».
Di positivo c’è che quando si impegnano le donne qualcosa succede. È d’accordo?
«Ne sono convinta. Perché abbiamo la capacità di metterci più passione. Anche se poi ci ritroviamo spesso una contro l’altra».
Si continua a scappare dalla Calabria?
«Sì».
Lei ha avuto la possibilità di andare via?
«Sì. Adesso sono sufficientemente vecchia, soprattutto ho tanti anni di servizio che nel giro di tre-quattro anni mi posso mettere in pensione».
Quando si pensa alla pensione vuole dire che le cose non vanno bene.
«Non vanno bene. Diciamo però che questa cosa la tengo in un angolino del cervello, non ci penso quotidianamente. Ho tanti obiettivi di ricerca cui voglio dare una risposta. Però, la situazione è veramente difficilissima. Dopo dieci anni siamo riusciti ad avere un fondo stabile che è dovuto passare come emendamento in un Consiglio regionale per iniziativa di due consiglieri, Antonio Borrello e Franco Pacenza, persone che tra l’altro non sono di Lamezia e che io conosco molto poco, anzi Pacenza non lo conosco affatto, che evidentemente si saranno sentiti motivati dalla mia battaglia. Come devo andare avanti? Ma ci credete o non ci credete in questa struttura? Se non volete, ditelo chiaramente. È assurdo che una struttura del genere debba morire perché a qualcuno salta lo schiribizzo che debba essere chiusa».
I soldi sono arrivati?
«Per ora è una vittoria di Pirro perché con l’accorpamento delle Asl non si capisce se arriveranno. Vigilerò, vigileremo tutti».
I prossimi risultati importanti?
«A giorni verrà comunicato l’isolamento di un nuovo gene a cui lavoriamo da quindici anni».
Dell’Alzheimer ormai si sa molto?
«Abbastanza. Con la sortilina annunciata a gennaio si è aggiunto un altro grande tassello».
Il manicomio di Girifalco è finito nella canzone vincente di Sanremo. Quando ha sentito Cristichi che ha provato?
«Un po’ di malinconia. La canzone mi è piaciuta anche se poi è Sanremo. Oddio, uno potrebbe avere un atteggiamento molto dicotomico: da un lato pensare che le canzonette un po’ involgariscono una sofferenza profonda, dall’altro che in tal modo questi temi vengono fuori. È altresì vero che questi ospedali psichiatrici erano anche una risorsa di cultura».
Non erano dei lager?
«Erano sicuramente anche dei lager perché lì c’erano malati che non dovevano esserci, i malati in osservazione per un trauma cranico, gli epilettici. C’erano ingiustizie terribili. Ma io ho scoperto nell’ospedale di Girifalco una biblioteca che era degna della Salpetriere. Dove sono finiti quei libri non lo so».
Che cosa è il cervello?
«Un territorio affascinante. Patologie psichiatriche apparentemente tali in realtà non sono altro che dei segni di esordio delle malattie. Per trent’anni uno può essere etichettato come un malato psichiatrico e poi te lo ritrovi con un quadro di violenza frontetemporale. Capire che cosa si sviluppa, perché e come… Resto sempre affascinata dal cervello che purtroppo non è in grado di studiare sé stesso fino in fondo. Pensi ad una persona che si definisce brava, ma è brava perché è empatica, cioè capace di relazionarsi con gli altri, e l’empatia non è altro che cellule. Questo non è riduttivo, è straordinario».
Siamo bombardati da notizie scientifiche del tipo: scoperta la zona del cervello che controlla il sonno, e via elencando.
«È un puzzle di una complessità incredibile».
A che punto siamo del puzzle? Alla cornice?
«Non le saprei dire. La cornice sicuramente sì. Si sta cercando di entrare in profondità».
La scienza sembra non avere più limiti. Pezzi di ricambio anche per il cervello?
«È molto più difficile. Non è ipotizzabile smontare e rimontare».
Ai suoi figli augura un futuro in Calabria?
«I miei due figli grandi sono all’università a Roma. È un’amarezza terribile vedere i figli che se ne vanno via. È giusto che abbiano periodi di distacco dalla famiglia, però è anche vero che noi siamo andati a sederci sui binari per avere l’università in Calabria. È amaro. Ma c’è una rivoluzione così grande che ci deve spingere a considerare la Calabria come un pezzo di Europa in cui siamo figli d’Europa e del mondo, andiamo e veniamo. Però i calabresi vanno solo, qui chi arriva? Gli albanesi e i marocchini, con tutto il rispetto per gli extracomunitari, però non arriva il colto. Se ci fosse lo scambio mi andrebbe benissimo, ma non c’è scambio. Noi continuiamo a restare come un’isola genetica, quasi come la Sardegna, e a rivaleggiare tra di noi».
Lei è una calabrese cocciuta?
«Cocciuto è un termine positivo o negativo? Se cocciuto è cocciuto, indica il coccio tosto. Si, assolutamente calabrese. Ariete con ascendente Leone».
Il suo sogno?
«Che questa struttura resti, che possa vivere di sé anche quando non ci sarò più».