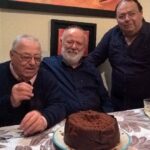di MATTEO COSENZA*
“Dopo otto giorni dal mio ritorno dall’Unione Sovietica cercherò di essere il più obiettivo possibile…”. “Discorsi pieni di parole e di citazioni nelle quali il nome di Lenin è abusato ed usato a sproposito…”. “Alla fine di tutte le conversazioni ci trovavamo pieni di parole ma privi di conoscenze…”. Il tono è questo, e non cambia di città in città, da Barnaul a Novosibirsk a Mosca, di fabbrica in fabbrica, tra i pionieri o nei kolchoz, negli incontri di partito. Il “paradiso in terra” non è quello immaginato e l’operaio che incarna la mitologia del Pci osserva e giudica e poi, il 28 agosto 1970, redige la sua lettera riassuntiva, un “rapporto” scritto con calligrafia minuta e pieno di errori grammaticali che io trasferii sulla macchina da scrivere. Il destinatario era Giuliano Pajetta, responsabile dell’Ufficio Fabbriche del Pci, il mittente era mio padre Saul, che, come di rigore nella tradizione del Pci, aveva finalmente compiuto il suo viaggio nel paese del socialismo e ora scriveva la sua relazione. Salvava l’idea del “mondo socialista”, ma che delusione la realtà del “socialismo reale”!
Di quel viaggio non mio, ma che un po’ sentii tale, mi sono rimaste le carte e il regalo che gli avevo chiesto di portarmi dall’Urss: un busto di Lenin. E, per quanto fossi vaccinato già da tempo, quale delusione anche la mia, venticinque anni dopo, nel settembre 1995, quando, dopo aver visitato come di rigore il Mausoleo della Piazza Rossa con la salma imbalsamata del protagonista della Rivoluzione d’Ottobre, in un negozio di Mosca comprai una t-shirt con il disegno di un canonico volto di Lenin con l’aureola a forma della M di McDonald’s e lo slogan: McLenin’s. L’allora grafico del “Mattino” e oggi art director del “Corriere della Sera”, Bruno Delfino, mi soprese con una delle sue genialate: fotografò la maglietta e disegnò la pagina del mio reportage per l’inserto domenicale riproducendola quasi a grandezza naturale. Il sogno di mio padre, un po’ ereditato e un po’ già ampiamente svanito, era finito su una bancarella.
In realtà io non cercavo Lenin ma non mi dispiacque quando in una vecchia libreria vidi alle spalle della titolare un piccolo busto impolverato di Marx, le chiesi quanto costasse e lei: «Niet, niet. Marx non si vende». Io ero lì nella speranza di trovare la mia Russia ma il lavoro mi imponeva di conoscere Mosca. Il mio desiderio principale si realizzò poi in una maniera singolare, ma di questo parlerò più avanti. Ora, dopo il tramonto di Gorbaciov c’era da raccontare la Mosca di Eltsin, da quattro anni al timone di un paese disastrato e a quattro anni da un clamoroso tentativo fallito di colpo di stato per estrometterlo.
In un cimitero puoi afferrare lo spirito di un luogo. Andai in uno di quelli più grandi della capitale russa, il Vagan’kovo. Il mio sguardo non si posò sulle stele dedicate ai caduti del partito e ai militi ignoti, ma sul punto più appariscente dell’inizio del vialone centrale. Stavano ancora finendo una orripilante scultura, una foglia celeste con una striscia grigia, alta due metri e mezzo e che un po’ invadeva anche il vialone. Era la tomba di un giovane di 26 anni, ucciso un paio di anni prima: un mafioso. Me ne ricordai molto tempo dopo quando Michele Albanese, giornalista sotto scorta da anni, volle farmi visitare il cimitero di Gioia Tauro: i quattro quadrati convergevano da ogni lato verso il centro dove si trovava, e non so se sia ancora là, la tomba di famiglia del potente boss della ‘ndrangheta di quella zona. Tutto il mondo è paese.
Ma per capire l’aria, almeno in quel periodo, poteva bastare non muoversi dal Sovinceter dove tra le tante cose c’era anche l’albergo. Nella immensa hall, ultramoderna e con una teoria di ascensori di cristallo a vista, si muoveva un popolo variegato, di uomini d’affari, faccendieri, prostitute. Osservare era già un modo per capire. Per esempio, un gruppo di sette uomini vestiti di nero si erano salutati battendo ognuno la propria spalla destra su quella destra dell’altro e cingendo con il braccio destro da dietro il collo la propria testa, infine una manata sulla spalla e un bacio. Era la mafia caucasica che lì si ritrovava, altri protagonisti emergenti della nuova Russia trattavano in ogni angolo.
Le strade di Mosca non erano meno eloquenti. A una flotta di vecchie auto più o meno sgangherate facevano da contrappunto tante ma tante Mercedes 600 nere, mai viste tante in una volta sola. Intanto la Russia si stava preparando al nuovo Zar che muoveva i primi passi alla corte di Eltsin.
Il vecchio sistema era stato sconfitto, la nuova nomenklatura si andava formando. Il mondo di prima viaggiava in auto con me. Anna Mavlyanova, una giovane fisica nucleare, mi faceva da guida “turistica”, la sua nuova professione. Nostalgica, mi ripeteva un ritornello: «Prima nei negozi non c’era niente e in casa tutto, ora nei negozi c’è tutto e in casa niente». Ma più significativo era l’autista proprietario di un’anziana Fiat 125, Boris Balaskov, un quarantottenne che aveva chiuso con il suo passato e ora faceva il tassista e, alla bisogna, anche da scuola guida. Era un ingegnere specializzato nelle onde corte, per 28 anni aveva lavorato in Siria, nella DDR e a Cuba per realizzare installazioni militari. Ancora vincolato dal segreto di stato, dopo giorni di frequentazione seppi che aveva lavorato per l’installazione di missili terra-aria a Cuba. E ora faceva l’autista nella sua città preoccupato soprattutto dei “missili” della polizia: «Quando ti fermano vogliono soldi, altrimenti ti fanno multe a volontà se non ti sequestrano anche la macchina».
Ma dov’era la mia Russia? Ne trovai un pezzetto in una bottega d’arte: un’icona con un numero incredibile di figure di cui mi innamorai subito. Un segno dell’anima di quell’immenso paese. La comprai e con qualche preoccupazione la feci passare alla dogana, poi una volta a casa mi fu detto che mi avevano fregato perché era una “crosta”. Me ne importava poco perché a me piaceva. Poi un giorno Eduardo Cicelyn, giornalista e cultore dell’arte, mi disse che Vittorio Baratti, esperto in materia, poteva dire l’ultima parola. Gli portammo la “crosta” e lui due giorni dopo mi sentenziò che era autentica: «Ho fatto solo un’incisione quasi invisibile e mi sono fermato perché ho visto che cosa c’è sotto».
Ma era destino che dovessi cercare in quel campo. A conti fatti il mio viaggio è un quadro. Nella galleria d’arte moderna, il direttore ci stava mostrando le opere nelle varie sale, quando mi colpì una tela che stava adagiata provvisoriamente nell’angolo di un corridoio e che con il contesto non sembrava essere in sintonia. Non so che valore avesse ma io vidi la Russia in quei colori, in quei paesaggi, negli alberi, nel contadino con i secchi, nella chiesa, nelle betulle, nelle mucche, negli uccelli su un ramo spoglio, nelle orme lasciate sulla neve, nel sole pallido. La Russia dei grandi scrittori, i più amati da me. Non solo Dostoevskij (qualche amico mi chiama Fëdor) che sono andato a cercare di recente a San Pietroburgo.
Ma lì sono stato distratto dalla mia guida, un professore di scuola superiore, che, per mettere le carte in tavola, mi ha mostrato con orgoglio il suo documento di identità nel quale risulta che è nato a… Leningrado. E nella meraviglia dell’Hermitage ci ha fatto una lezione nella non grande stanza in cui si riunì il primo governo della Rivoluzione. Con gli occhi abbagliati dall’arte ma anche dall’infinito parquet, dalle montagne di marmi, oro e qualsiasi prezioso metallo si ricavi dalla Terra, ho capito che quella Rivoluzione, al di là dei suoi esiti, non poteva avvenire che in Russia, tanto stridente era il contrasto con le condizioni del popolo. Quanto a “Delitto e castigo” e agli altri capolavori dostoevskiani sarà per un’altra volta, se mai ci sarà, per stare con loro mi riparo al caldo della mia biblioteca.
Ma torniamo a Mosca dove pensavo a Tolstoj, non a quello dei tre grandi romanzi bensì ai racconti, alle migliaia di pagine di una scrittura soave e penetrante, o alle anime morte di Gogol, ma soprattutto a Cecov, che di romanzi ne ha scritti pochissimi ma ci ha lasciato un piccolo gioiello, quasi un racconto più lungo, il viaggio, ci risiamo, di un bambino, Egòruška, dalla casa natale alla città in cui una famiglia lo adotterà per farlo studiare. Attraversa la “steppa”, da cui il titolo dell’opera, la vastità dei suoi orizzonti, la sua asprezza e aridità e poi gli squarci di umanità, le locande con i cortili coperti, le minestre, i samovar, la raccolta della lana, le notti rischiarate dalla luna che pare un sole, la nuvola improvvisa che esplode in una pioggia impetuosa…: «Non vi erano più colline e ovunque si guardasse si stendeva una pianura sconfinata triste e bruna; qua e là sorgevano piccoli tumuli e volavano le gracchie. Più avanti, in lontananza, biancheggiavano i campanili e le isbe di qualche villaggio… per due minuti tutto fu silenzio, come se il convoglio si fosse addormentato; si udiva soltanto smorzarsi in lontananza il rumore secco del secchio che ballonzolava legato alla parte posteriore del calesse».
Non so quando restai a fissare quel grande quadro che era ai miei piedi. Doveva essere mio. Ma per quanto studiassi il modo non riuscii a trovare una soluzione e capii, senza tanta convinzione, che dovevo rinunciarci. Tornai a casa, al mio lavoro. E dopo qualche mese il ricordo fu accantonato. Un pomeriggio, era appena iniziata l’estate, mi arrivò una telefonata. Era Anna, la fisica nucleare, che mi diceva che con un gruppo era venuta dalle nostre parti, che si trovava a Minori e che aveva un regalo per me. Andai incuriosito. Con lei c’era il direttore della galleria d’arte moderna. Mi avevano portato il quadro. Credo che l’abbiano fatto proprio per vedere la mia reazione, ma non saprei. Chiesi che cosa dovessi. «Nulla, è un regalo della Russia». Si ricordavano di quella mia emozione nella galleria della loro città e quasi mi volevano sentire vicino come se fossi un russo autentico anche io. Faticai molto almeno per dargli i soldi che avevano dovuto pagare alla dogana, poco più di centomila lire. E infine li salutai. Non ho più saputo nulla di loro. Ma ho quel quadro e quel quadro è la Russia, e un viaggio, per quanto appeso a una parete, può non finire mai.
*MATTEO COSENZA (*nato nel 1949, è un giornalista. Napoletano di Castellammare di Stabia, meridionale con un quarto calabrese, italiano a 24 carati, nonostante tutto europeo, ospite transitorio della Terra)
Fonte: https://www.foglieviaggi.cloud/blog/la-mia-russia-in-un-quadro-di-mucche-e-betulle